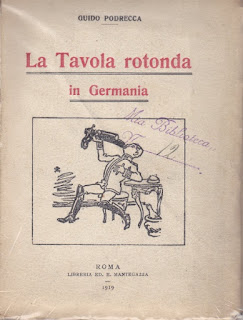«C’è un solo uomo di troppo sulla
Terra: il reverendo Malthus».
*
«Però,
se è vero che l’ineguale distribuzione della popolazione e delle risorse
disponibili crea ostacoli allo sviluppo e ad un uso sostenibile dell’ambiente,
va riconosciuto che la crescita demografica è pienamente compatibile con uno
sviluppo integrale e solidale. Incolpare l’incremento demografico e non il
consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per non affrontare i
problemi (Laudato si’, pp. 38-39).»
*
Quanto
“all’ineguale distribuzione delle risorse disponibili” va chiarito che nel
capitalismo la ricchezza materiale non esiste per i bisogni di sviluppo del
lavoratore ma che questi esiste per i bisogni di valorizzazione del capitale.
Pertanto anche le “problematiche” demografiche, e con esse quelle della fame e
del sottosviluppo, devono essere ricomprese nelle leggi di accumulazione e
sviluppo capitalistico se si vuole restare nell’ambito dell’analisi scientifica.
Tutte
le trasformazioni avvenute nei modi di produzione precedenti non hanno mutato
sostanzialmente i rapporti di produzione, limitandosi a sostituire una forma di
proprietà ad un’altra, una forma di sfruttamento con un’altra. Dalla proprietà
schiavistica, a quella feudale, poi alla proprietà capitalistica: dallo
sfruttamento degli schiavi si è passati allo sfruttamento dei servi della gleba
e ora a quello dei proletari (anche di quelli che stanno partendo per le
vacanze con l’auto nuova).
Ciò
è avvenuto anzitutto con l’espropriazione dei produttori immediati, con la
dissoluzione della proprietà privata fondata sul lavoro personale. I produttori
diretti vengono separati violentemente dai propri mezzi di produzione, essi
diventano “liberi” perché devono essere liberi di vendere la propria
forza-lavoro, liberi di farsi sfruttare. E liberi di credere alle incessanti
panzane che vengono raccontate sulla loro condizione.
Ed
è ciò che, da ultimo, sta avvenendo prepotentemente in Africa e in Asia laddove
i produttori immediati, contadini e piccoli artigiani, vengono separati
violentemente dai propri mezzi di produzione. Si crea in tal modo una massa di
potenziali lavoratori “liberi” di cui solo una parte può essere impiegata come
schiavi salariati in loco. Gli altri devono arrabattarsi come possono o
emigrare. O morire perché non hanno abbastanza da mangiare.
Lasciano
i campi e le fattorie, a occuparsi della produzione di cibo saranno le
multinazionali. A queste importa soltanto le coltivazioni intensive di grano,
riso, soia, il resto è spazzatura. Invece in ogni piccola fattoria, in ogni
villaggio si coltiva di tutto, perché tutto è cibo. Invece di incoraggiare la
gente a produrre il proprio cibo, a farsi carico della propria fame, alle
multinazionali conviene di più l’affamato perché è una persona da sfruttare in
ogni senso.
L’India,
per esempio. Ci sarà pur un motivo se in molte zone dell’India prospera il
maoismo: è uno dei paesi più grandi esportatori di cibo con il più alto numero
di denutriti del mondo (*). Altro esempio: in Madagascar l’80 per cento della popolazione
vive prevalentemente di riso, un tempo ne era prodotto per sfamare tutti, oggi non
più ed è importato. Viene importato più riso del necessario dai grandi mercanti,
in tal modo il prezzo scende e la produzione locale ne subisce la concorrenza.
Circa il 45 per cento dei contadini ha fame secondo il relatore speciale
dell’ONU per i diritti all’alimentazione Olivier de Schutter (**).
Nei
paesi a più antica industrializzazione sta avvenendo un processo diverso ma con
analogo risultato e che riguarda la disoccupazione: l’aumento della massa dei
mezzi di produzione a paragone della massa della forza-lavoro che li anima, si
rispecchia nella composizione del valore del capitale, ossia nell’aumento della
costitutiva costante del valore capitale a spese della sua parte variabile.
Ci
troviamo dunque di fronte a due aspetti diversi del problema demografico ma che
hanno in sé un’unica causa: lo sviluppo capitalistico. Nei paesi raggiunti dall’espansione
capitalistica assistiamo all’espulsione dei produttori diretti dalle loro condizioni
di lavoro e di vita, vuoi per espropriazione diretta o perché soccombenti alla
concorrenza dei prodotti importati. Nei paesi a capitalismo maturo, invece,
assistiamo allo stesso fenomeno, nelle specie della disoccupazione (o precarizzazione) di massa,
dovuto però alla mutata composizione organica del capitale (nuove tecnologie).
Là
il processo è indotto dall’espropriazione “legale” delle terre, in cui le
popolazioni hanno vissuto per secoli, dalla concorrenza, dallo strangolamento
per debiti e dalla miseria più nera creata ad hoc. Qui, invece, l’accumulazione
capitalistica produce costantemente e in proporzione della propria energia e
del proprio volume una popolazione operaia relativa, cioè eccedente i bisogni
medi di valorizzazione del capitale, e quindi superflua (***).
In
entrambi i casi, questa
sovrappopolazione diventa la leva dell’accumulazione capitalistica e addirittura una delle condizioni d’esistenza del modo
di produzione capitalistico. Essa costituisce un esercito di sfruttati di
riserva, disponibile e che appartiene al capitale in maniera completa per i
mutevoli bisogni di valorizzazione, materiale umano sfruttabile e sempre
pronto, indipendentemente dai limiti del reale aumento della popolazione (si sopperisce con gli immigrati). Il
ciclo economico odierno, che si alterna con brevi oscillazioni di vivacità e
prolungati periodi di crisi e stagnazione, ha un rapporto diretto sul maggiore
o minore assorbimento della sovrappopolazione.
Nei
sedicenti sistemi comunisti la colpa dei problemi sociali era attribuita allo
Stato, il quale si era fatto carico di provvedere a tutto. Nei sistemi
capitalistici i fenomeni della povertà, della disoccupazione, dell’emigrazione
forzata, sono visti e spacciati invece come il prodotto delle più diverse cause,
spesso intese come colpe individuali o di singoli gruppi, ma in realtà quei
fenomeni hanno essenzialmente radice nel capitalismo e nelle sue
contraddizioni. Ammetterlo significherebbe mettere in discussione il sistema,
un po’ come se nel medioevo si fosse messo in dubbio la verità del
cristianesimo.
Il
Vangelo dice che i poveri ci saranno sempre. È una realtà antica. Oggi abbiamo incontestabilmente
i mezzi per sconfiggere la miseria e la fame per sempre. Nella Terra produciamo cibo più che sufficiente per
sfamare tutti. Molto più cibo con solo l’8% delle terre coltivate in più
rispetto al 1960. Il capitale ha bisogno di nuove terre da mettere a cultura
intensiva. Non per sfamare le famiglie che sono cacciate da quelle terre – nessuna
risorsa per gli inutili – ma per aumentare i profitti.
La
verità è che il capitalismo, nel suo imponente sviluppo, non sa che farsene di
centinaia di milioni di persone, quando non sono masse di riserva sono “eccedenze”.
In un sistema in cui gli individui si definiscono per il loro ruolo nella
divisione sociale del lavoro, la disoccupazione diventa uno dei modi per
privarli di un’identità, o di dar loro un’identità definita dalla mancanza. Li
chiamano quelli che non studiano né lavorano. Quelli che affogano nel
Mediterraneo non li chiamano nemmeno.
Finché
la povertà resterà un problema altrui non ce ne importerà nulla o ce ne
occuperemo molto solo a parole. Colpevoli senza colpe. E anche quando la
povertà ci riguarda direttamente abbiamo un motivo in più da opporre per non
occuparci di quella altrui. Tuttavia anche in tal caso non si può dire che il
problema non ci tocchi direttamente, tanto più quando i migranti sbarcano. È a
questo punto che scatta la paura, ben fomentata e gestita per interessi
elettorali.
Il
capitale agisce globalmente e invece i governi sono locali, e anche quando
potrebbero fare qualcosa insieme non decidono. Sappiamo altresì che non è in
nostro potere come singoli individui cambiare le cose, ma questo non è un buon
motivo per non fare nulla. E oggi fare qualcosa significa se non altro prendere
posizione e fare chiarezza, chiamando le cose per nome.
(*)
Nel 1996 una grande conferenza di capi di Stato alla Fao s’impegnò di dimezzare
il numero degli affamati nel 2020. Allora erano 850 milioni; da allora circa
120 milioni di persone sono morte senza che importasse nulla a nessuno, e
tuttavia continuano a esserci circa 900 milioni di affamati. Dal 2008 si sono
spesi oltre 20.000 miliardi di dollari in “pacchetti di stimoli” per salvare le
banche e i grandi gruppi finanziari.
(**)
Le Rapporteur spécial a pu constater,
lors de sa mission, les impacts de l'incertitude politique et de la suspension
de l'aide sur la sécurité alimentaire: 35 % de la population rurale a faim – un
chiffre qui s'élève à 47 % parmi les petits agriculteurs et à 43 % parmi les
travailleurs agricoles journaliers –, et 50,1 % sont vulnérables à l'insécurité
alimentaire.
(***)
In nessun altro periodo della sua storia il capitalismo ha visto impiegato al
contempo un così alto numero di salariati su scala mondiale così come in
nessun’altra congiuntura ha visto il formarsi di un tale esercito industriale
di riserva. L’aumento degli operai viene creato, da una parte, mediante un
processo semplice che ne “libera” costantemente una parte separandola
violentemente dai propri mezzi di produzione; dall’altra in virtù di metodi che
diminuiscono il numero degli operai occupati in rapporto alla produzione
aumentata, e dunque dalla costante trasformazione di una parte della
popolazione operaia in braccia disoccupate o occupate a metà. Ciò, tra l’altro,
comporta un maggiore controllo sui movimenti generali del salario.